I n V i g n a
la proprietà
Q u e s t i o n e d i T e r r o i r e
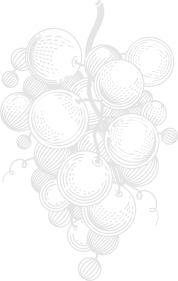
restituire prima di tutto
R e s p o n s a b i l i t à N a t u r a l e
Alla base del nostro approccio alla viticoltura c’è l’obiettivo di riportare il terreno e l’ambiente alle sue caratteristiche fisiche e strutturali originarie. Vogliamo permettere alle colture di svilupparsi al meglio, esaltando le loro peculiarità in termini di salute e qualità dei frutti. Da anni, con l’aiuto di un biologo, sperimentiamo l’uso di lieviti e prodotti fermentati per ridurre al minimo l’impiego di principi chimici nella difesa e nella concimazione della Vite. Sperimentare è alla base della nostra quotidianità: collaboriamo con gli erboristi per studiare la chimica delle piante, dei lieviti e le loro interazioni. Privilegiamo tecniche alternative a basso impatto ambientale e metodi naturali per concimare il terreno.


Il concime è una componente essenziale per noi, poiché riconosciamo l’importanza di restituire al terreno la sostanza organica di cui spesso è carente, e lo facciamo in modo naturale, evitando l’uso di concimi ternari e chimici come l’azoto. Preferiamo utilizzare letame maturo e letame di lombrichi, così come concimi fermentati, monitorando attentamente l’azione dei lieviti nel terreno per garantire l’introduzione di organismi non invasivi. Ultimamente, ci siamo orientati verso gli EM (micro organismi effettivi) che, nutrendosi della sostanza organica, contribuiscono a formare acidi unici che agiscono da ponte con le radici, facilitando l’assimilazione delle sostanze nutritive da parte della pianta.
"Il Buon Vino si fa in Vigna"
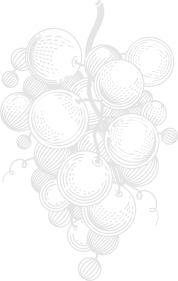
– Fratelli Demaria
La gestione della vigna per noi, Demaria, è tradizionalmente minuziosa e attenta. Crediamo che un drastico abbassamento delle rese conduca a maggiore intensità e distinzione aromatica. Perciò, attuiamo un’attenta selezione e diradazione delle nostre uve.
Potatura e diradamento sono attività che ancora oggi, come sempre, svolgiamo personalmente noi fratelli.
tecniche tramandate
C u r a e D e d i z i o n e


certificazione sqnpi
L a L o t t a I n t e g r a t a : l a N a t u r a C u r a l a N a t u r a
Dall’anno 2018, i nostri vini sono certificati SQNPI, una certificazione che riguarda la lotta integrata, ovvero l’integrazione tra il convenzionale e il biologico quando possibile.















